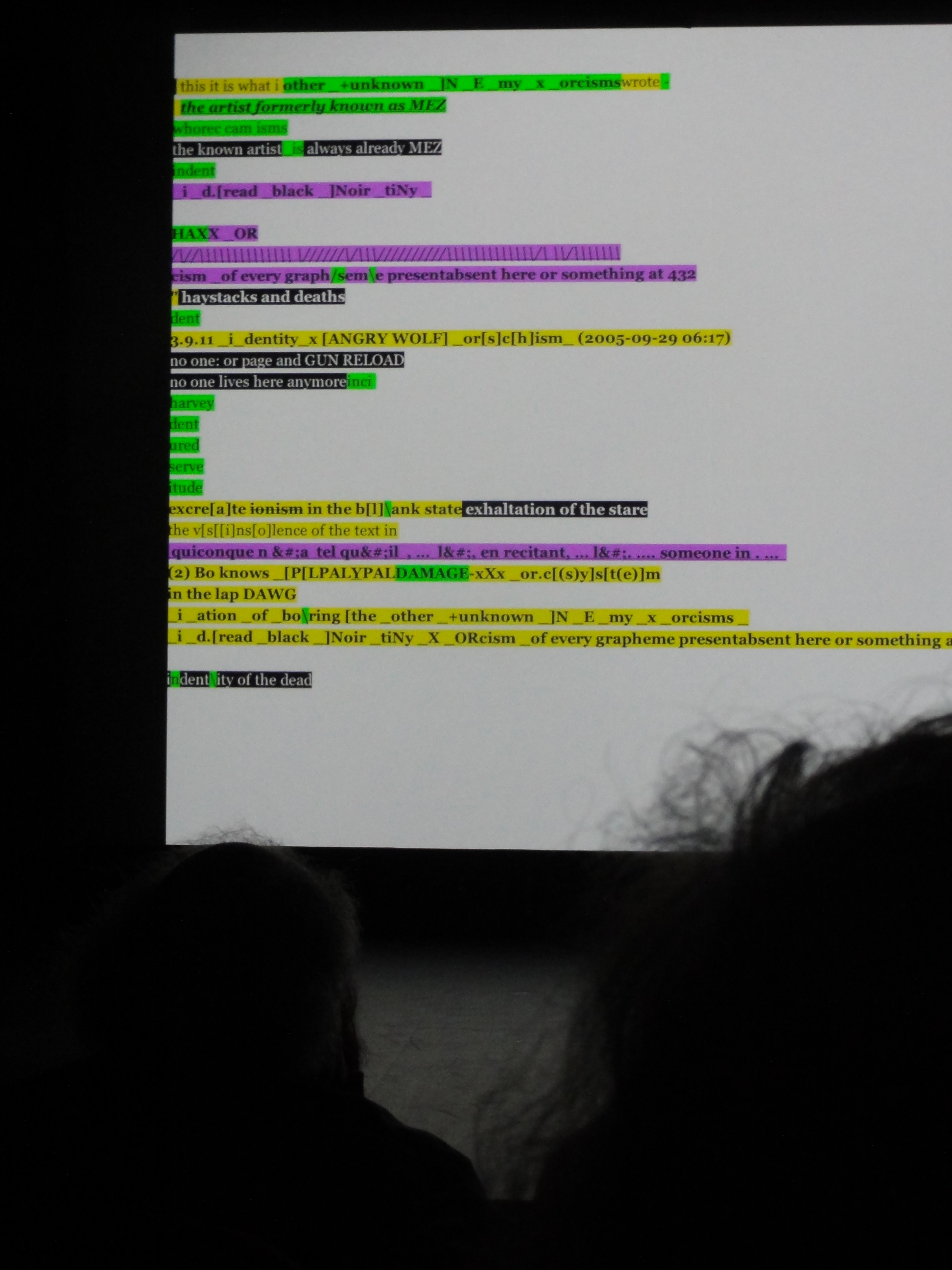di SIMONA POLVANI
_________________________________________________________________________________________
I. PROLOGO
AGLIANA 05_09_2021
Non scrivo di televisione né di musica, solitamente. Scrivo di arti performative e di arte contemporanea. Scrivo di performance. E l’atto di scrivere non avviene mai senza aver visto in live un(’)artista e averci condiviso uno spazio d’aria.Il testo che leggerete nasce in assenza di tale spazio e di live. È frutto di una posizione equivoca, quella di una spettatrice televisiva che guarda una performance musicale in una nota kermesse canora italiana, il Festival di Sanremo. Pur consapevole di essere di fronte a uno schermo e a una performance televisivi, da una parte prova a bucarlo, come lo buca l’artista di cui ha deciso di scrivere, dall’altra a trattarla come una performance teatrale live. Come se i miei occhi potessero muoversi davvero su tutti i lati di un palcoscenico, gettarcisi dentro, coglierne ed isolarne i dettagli, e non fosse invece l’occhio della telecamera, inquadrando, a stabilire e imporre il punto di vista, nella logica di una ricerca di effetti che “niente pare davvero far vedere”, almeno secondo la libertà di sguardo della spettatrice teatrale che sono. Si tratta di un esperimento da equilibrista, frutto di un periodo – pare esagerato ancora definirlo epoca – in cui la pandemia del covid-19 ci ha privati dello spazio del respiro comune in ogni ambito e in particolare nel mondo dello spettacolo e dell’arte, condannati a prolungate chiusure. L’urgenza di scriverne, nella procrastinazione di un live diventato impossibile, si è diluita ma non persa. Piegata come un giunco – strategia di sopravvivenza che ho rivaluto –, essa si è radicata nel disegno di un ritratto d’artista, a distanza, anche temporale. Lasciato decantare il diktat dell’attualità, è il caso di dire “chi se ne frega”. Dalla primavera riemerge adesso, en septembre.
___________________________________________________________________________________________________
II. IL CORPO
PARIGI 22_04_2021
”È giunto il nostro momento. La nostra stessa fine in questa strana fiaba. La più grande storia raccontata mai. Maschere dissimili recitano per il compimento della stessa grande opera. Tragedia e commedia. Essenza ed esistenza. Intesa e incomprensione. Elementi di un’orchestra troppo grande per essere compresa da comuni mortali. È giunto il nostro momento. Colpevoli, innocenti. Attori, uditori. Santi, peccatori. Tutti insieme sulla stessa strada di stelle. Di fronte alle porte del Paradiso. Tutti con la stessa carne debole. La stessa rosa che ci trafigge il petto. Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita. E così sia. Dio benedica Solo Noi Esseri Umani”
(Achille Lauro, Quinto quadro, Sanremo 2021)
“Ceci n’est pas une pipe” (Questa non è una pipa), scriveva Magritte nel suo celebre dipinto La Trahison des images (1928-29), sotto la raffigurazione di una pipa, creando a prima vista un paradosso, mentre affermava il principio che la rappresentazione pittorica di un oggetto non è l’oggetto stesso.
“Performance teatrali in quattro minuti” e “quadri”, tra arte figurativa e tableau vivant, definisce Achille Lauro le sue quattro esibizioni musicali di Sanremo 2020 e le cinque creazioni – una per ogni sera del festival – che ha realizzato come ospite d’onore per Sanremo 2021.
Di riferimenti al teatro sono disseminate le sue canzoni, dove si incontra persino la parola “teatralità” (brano Come me, album Lauro, 2021). Del resto, il suo romanzo di esordio si intitolava Sono io Amleto (Rizzoli, 2018). Può apparire rischioso avventurarci in questa seppur breve analisi dal punto di vista scenico di performance – nel senso largo di “esibizione”, “spettacolo” – la cui natura prima è incontestabilmente musicale, e che sono concepite all’interno di un festival che è un programma televisivo.
Tuttavia, questa rivendicazione di genere artistico da parte dell’artista romano, e quindi in un certo senso di sconfinamento del genere, assieme ad alcuni elementi scenici propri delle sue performance, ci sembrano argomenti legittimi per interessarsi alle sue esibizioni anche dal punto di vista teatrale e performativo.
SANREMO 2020, SLIDES DI PERSONAGGI
Che la musica possa essere al centro di performance teatrali, come filo conduttore (trama e personaggio) e non semplicemente come elemento di sottolineatura o generatore di atmosfere, non è una novità. Il riuscitissimo spettacolo MDLSX (2015) dei Motus si snoda nell’esperimento di un Dj/Vj set mirabolante della performer Silvia Calderoni. “Performance-Mostro”, secondo la definizione dai suoi autori, essa si propone come “un inno alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una Patria”. Temi e intenti che ritroveremo nelle performance di Achille Lauro, così come l’idea formale della fuoriuscita dai generi, anche artistici. Mentre Silvia Calderoni nel perseguimento di tali visioni introduce in MDLSX la musica come elemento di rottura della performance teatrale, Achille Lauro fa un movimento inverso. Nelle performance musicali sperimenta una ricerca sulla teatralità, cimentandosi in una forma di spettacolo basata sul travestimento. Per quanto in Italia già introdotta quaranta anni fa da Renato Zero, come lo stesso Achille Lauro riconosce, essa rompe con l’esibizione musicale classica nell’ambito del rock-pop.
Per il brano Me ne frego, proposto a Sanremo 2020 in duo con il chitarrista e producer Boss Doms, Achille Lauro, assieme al suo art director Nicolò Cerioni ( e al suo produttore Angelo Calculli), costruisce una performance in cui nella ripetizione pressoché invariata ogni sera della partizione gestuale, evoca, senza recitarli, San Francesco, David Bowie/Ziggy Sturdust (già maestro sublime del glam rock), la Marchesa Luisa Casati Stampa e la regina Elisabetta I Tudor. Si tratta di figure scelte come emblemi di rottura e anticonformismo, funzionali a un discorso sulla libertà e la liberazione dagli stereotipi di genere. Ognuno dei personaggi è rappresentato attraverso un riferimento iconografico e/o gestuale (per esempio la spogliazione del mantello per San Francesco), e incarnato in un costume specifico che agisce come catalizzatore scenico, frutto della collaborazione con lo stilista Alessandro Michele per Gucci. L’iconica Maison italiana ha fatto della fluidità di genere l’ossatura delle sue ultime collezioni, interventi nel mondo dell’arte e scelta di testimonial: Achille Lauro e la stessa Silvia Calderoni, che è protagonista del film in sette episodi Ouverture Of Something That Never Ended, diretto dal regista pluripremiato Gus Van Sant e da Alessandro Michele. I costumi firmati Gucci per le performance di Lauro non sono solo glamour, ma strepitosamente belli. Grazie alla loro strutturazione architettonica e alle scelte cromatiche e materiche, contribuiscono a introdurre una componente plastica nella dimensione scenica, tra pittura e scultura. Mai didascalici, estraendo un motivo simbolico emblematico, lo reinterpretano e attualizzano, in una miscela di passato e presente, segni femminili e maschili. Reinventano un’immagine futura sui generis. Nessun personaggio, nella stratificazione, appare univoco. La trasparenza delle citazioni impedisce inoltre che Achille Lauro in scena sia sempre “solo se stesso”. Come egli dichiara, non si tratta infatti “di interpretare un personaggio, ma di indossarne gli abiti”. Tale assenza di personificazione, riconoscibile, fa sì che il corpo di Lauro e la sua identità restino visibili e presenti oltre il costume. Ne risulta una performance ibrida, per sovrapposizioni, dall’apparenza fluida e magnetica, in cui coesiste il personaggio evocato con la persona – anche in senso di maschera – di Achille Lauro, performer, rock star che indossa l’abito di un’altra figura.
La presenza di Boss Doms, partner in crime di Lauro, diventa il fulcro del discorso sui generi. Il bacio che con un gesto finanche rapace, l’artista sera dopo sera imprime sulla bocca di Boss Doms, oltre a concretizzare la manifestazione di un desiderio omosessuale sul palco sanremese, costituisce un rituale di smarcamento rispetto ad assegnazioni definite di genere sessuale, tanto più nel rifiuto categorico di Lauro di identificarsi in un orientamento sessuale definito come etero o omossessuale o nell’identità binaria.
SANREMO 2021, TABLEAUX VIVANTS
Per Sanremo 2021, il dispositivo si struttura attorno a una costruzione scenico-drammaturgica che intende acquisire maggiore complessità. Innanzi tutto, non si tratta più di “indossare” un personaggio diverso per lo stesso brano musicale, ma di costruire cinque tableaux vivants per altrettanti pezzi rappresentativi dei generi musicali del glam rock, del rock & roll, del pop, del punk, attraverso canzoni del repertorio dello stesso Lauro: Solo noi per il glam rock; Bam Bam Twist per il rock & roll, Penelope per il pop, Me ne frego per il punk, ed infine C’est la vie come omaggio alla atmosfere orchestrali che appassionano Lauro. La finalità è cogliere “l’essenza” di tali generi, ricorrendo a una costruzione allegorica. Per realizzarla, Achille Lauro, accompagnato ancora da Nicolò Cerioni, ricorre alla produzione, combinazione e sovrapposizione di immagini, che sono a loro volta il prodotto di un procedimento citazionale, da sempre la sua cifra poietica ed estetica anche nelle creazioni musicali.
La visione allegorica, per quanto trovi in Lauro il suo centro, non è più solo “indossata” da lui, attraverso i costumi, alcuni particolarmente sorprendenti, creati ancora da Alessandro Michele/Gucci. Essa è condivisa e disseminata tra gli artisti ospiti invitati a recitare, danzare, cantare, suonare nei quadri: Monica Guerritore, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Emma Marrone, Fiorello, Boss Doms, il danzatore Giacomo Castellana. Figure reali del panorama musicale o fittizie della mitologia greca, spezzoni di film, opere dell’arte classica e contemporanea, simboli della religione cristiana, si iscrivono e sono portati, quindi, anche con verve ironica e a tratti iconoclasta, dai corpi di Lauro e degli altri artisti protagonisti.
Senza voler ripercorrere i tanti giochi di rimandi presenti nei vari quadri, ci limitiamo a fornire alcuni elementi che permettano di considerare la pluralità di riferimenti e suggestioni che si intrecciano e stratificano nelle varie performance. Nel primo quadro, con una chioma azzurra sfrangiata, Achille Lauro rende omaggio al glam rock, indossando un costume da angelo combattente e Cupido. È una evocazione inequivocabile del personaggio del cantante Brian Slate, già ispirato a David Bowie, interpretato dall’etereo Jonathan Rhys Meyers, nel film capolavoro Velvet Goldmine (1998), che proprio del glam rock traccia la storia.Nel quadro dedicato al pop, Monica Guerritore recita un breve intenso monologo ispirato al mito di Penelope, rivisto in chiave femminista. Tutta la scena risulta ispirata all’epoca classica. All’interno di una scenografia di colonne antiche e alberi dorati, Lauro con peplo e corona d’alloro, interamente dipinto d’oro, in piedi su una stele, statuario e fragile a un tempo, duetta con Emma Marrone, anche lei tutta in oro. La coppia Claudio Santamaria e Francesca Barra mima Vincent Vega/John Travolta e Mia Wallace/Uma Thurman nel celebre twist del film Pulp Fiction, per il quadro sul rock & roll, mentre Lauro si cimenta nella citazione di Mina. Ispirandosi a una serie di foto della cantante, realizzate negli anni ’80 da Mario Balletti, ne riproduce trucco e acconciatura, giocando con una diavolesca lunghissima treccia rossa. Per il quadro sul punk di Me ne frego, Achille Lauro ritrova Boss Doms. In versione sposa, il primo, fluttua in un candido abito–nuvola di piume di struzzo e organze, imbracciando la bandiera italiana, come una nouvelle Liberté guidant le peuple di Delacroix. In tailleur bianco e ornato di velo nuziale, Boss Doms riceve il suo bacio, come a Sanremo 2020, a suggellare il connubio. La performance si vuole però anche omaggio a Sid Vicius dei Sex Pistols nella sua caustica interpretazione di My Way.
Per quanto si ricorra certo ad alcuni processi di teatralizzazione, questa – ed è ciò che risulta interessante – non risulta mai completa, perché la maschera e i ruoli che Achille Lauro di volta in volta “recita” appaiono solo come una delle tante sfaccettature cangianti del suo corpo, al contempo impacciato, enigmatico, fragile e guerriero, e del suo volto imprendibile. Risalta l’energia pulsionale, che attraversa le interpretazioni. A volte incanalata in un’immobilità apparente, altre debordante in cascate, scivolate e rotolate a terra repentine, a cui ci hanno abituato molte star del rock e punk, appare in una partitura di gesti probabilmente prestabiliti, ma che non si organizzano in una coreografia millimetrata, lasciando spazio a un margine vitale di improvvisazione.
Dal punto di vista della composizione, ogni quadro è completato da un’opera video, in bianco e nero, che attraverso un processo di dissociazione, cristallizza come icona un momento della performance live di Achille Lauro, mentre la voce recita in sottofondo testi poetici, impregnati di immaginario teatrale. Definiti “lettere”, in forma di appello e preghiera rivolti al mondo come a un ipotetico Dio creatore dell’umanità, essi rappresentano i manifesti esistenziali e politici dei quadri.
L’iconografia religiosa cristiana, da sovvertire, attraversa le performance e segna anche i momenti di incursione dell’artista nel territorio della body art, di cui alcune pratiche di mutilazione sono ricreate fittiziamente a uso drammatico e spettacolare. Nel primo quadro, le lacrime di sangue grondanti sul viso dell’artista rimandano immediatamente alla lacrimazione della Madonnina di Civitavecchia – come Achille Lauro riconosce. Altri riferimenti ci paiono suggestivi. Ancora nel mondo del pop-rock, il sanguinamento portato in scena da Lady Gaga (MTV 2009). In quello della body art, in particolare di area romana – la stessa in cui Achille Lauro si è formato – un precedente pare costituito dalla performance Human Installations III (2009) di Kyrahm, in cui l’artista stilla dalle palpebre vero sangue. Nell’ultimo quadro, con la sua interpretazione suggestiva della canzone C’est la vie, Lauro si presenta con il petto trafitto come un ex voto da tre rose rosse e si offre agli insulti in sottofondo dei suoi haters. Il richiamo all’iconografia della Vergine addolorata, rappresentata con una rosa in petto e la spada, e insieme a gran parte della storia della body art, appare evidente. Ma anche in questo caso non si tratta che di una citazione. Mentre nella body art le mutilazioni e sofferenze che gli artisti si infliggono sono infatti reali, nel caso delle performance di Achille Lauro, si tratta di finzione scenica, creata grazie ai magistrali interventi di Andrea Lanza, esperto di special make-up per il cinema. Si realizza un “come se” – ciò che secondo Richard Schechner costituisce la differenza tra teatro e performance –, producendo sì un effetto spettacolare, ma riducendo in parte la portata dell’evento. Nel trompe l’oeil, la realtà risulta così una finzione, artificio.
PERFORMARE IL GENERE
Come per le performance a Sanremo 2020, anche per quelle di Sanremo 2021, ogni rappresentazione vale per sé, ma acquisisce senso come gesto e come visione unitaria. Non tutti i tableaux sono apparsi convincenti, dal punto di vista del dispositivo drammaturgico e dei suoi snodi. Debolezze risultano nella gestione della compresenza di situazioni sceniche di diversa natura (canto/danza/recitazione), anche a causa dei limiti di un palcoscenico, come quello sanremese, troppo ingombrante e connotato scenograficamente, che sarebbe arduo se non impossibile far diventare neutro. La stessa regia televisiva a volte è risultata inadeguata.
Resta tuttavia il valore performativo dell’esperienza proposta da Lauro. Il discorso sui generi musicali si è rivelato ancora funzionale ad affrontare le questioni di genere. Fotografando la condizione storico-sociale dell’emergenza e dell’affermarsi di un genere di musica, come atto rivoluzionario rispetto a uno status quo, e denunciando la natura dei pregiudizi di varia natura (sesso, razza, condizione sociale…), i quadri invocano e incitano alla liberazione, verso la realizzazione di un’identità anarchica, autarchica e autonoma, indipendentemente dai valori imposti dalla cultura dominante e patriarcale. Per costruire tale discorso su genere e identità, Lauro dispiega un immaginario “di sintesi” proprio, risultato della rielaborazione e dall’assemblaggio di esperienze umane ed artistiche varie, – nella combinazione di un dispositivo musicale-teatrale-performativo, di live e video. Il suo corpo rimane performativo, nella porosità di presenza reale e costanti ricerche di artificio e metamorfosi, portatore di domande anche quando invece la sua voce nelle “lettere” parrebbe formulare affermazioni e dare risposte.
Se la performatività attiene, come tra gli altri lo stesso Schechner e Judith Butler sostengono, alla ricerca e alla costruzione di identità attraverso un processo di ripetizione di comportamenti, nel loro tentativo di decostruzione di regole e ruoli sociali costrittivi e nella sommatoria delle ripetizioni che propongono, le performance di Achille Lauro contribuiscono a performare la realtà e le identità, ossia in un certo senso, a ri-costruirle, rendendole più effettive secondo una visione propria. Come gesto politico di autodeterminazione, “essere genericamente niente”, come Achille Lauro sostiene, può rappresentare allora la porta di accesso a un paradiso di spazi di autenticità sconfinati.
___________________________________________________________________________________________________
III. ELEVATIONS
PARIGI 20_06_2020
Negli Airpodes in loop una scia di brani di Achille Lauro, riflettendo a un’intervista che vorresti fare.
È la vigilia del solstizio d’estate. Da quando la pandemia ha avuto inizio, il corpo tenuto lontano persino dall’aria. Passi esplodono nel disegno di una personale mappatura di Parigi, che ritracci ora, da mesi di assenza. Les Tuileries sono un terreno di gioco, levitazione dell’essere aspirato dalla luce in diagonale. Gioco di riflessi. Presenza in trasparenza. La parte in ombra. L’impronta.