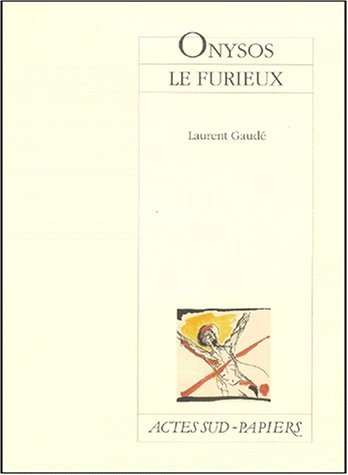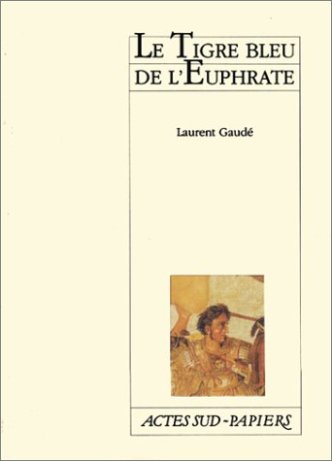ONISIO FURIOSO
di Laurent Gaudé
traduzione di Simona Polvani
Onìsio Furioso (Onysos le furieux) è il secondo testo teatrale di Laurent Gaudé, pubblicato nel 2000 e messo in scena lo stesso anno da Yannis Kokkos.
Un uomo è seduto sulla banchina di una metropolitana, a New York. È vecchio. Vestito di stracci. È Onìsio, uomo e dio. Prende la parola e scioglie il racconto della sua vita. È un’epopea antica. Dalla nascita sui monti Zagros fino alla conquista di Babilonia, dalla fuga in Egitto all’arrivo nella città di Ilio dove decide di morire al fianco dei Troiani racconta una lunga successione di pianti e grida di piacere, lacrime, orge e incendi. In una notte, su una banchina anonima, Oniso l’accattone, dal viso di fango, Oniso l’assetato fa sentire di nuovo la sua voce e ricorda agli uomini che ancora esiste.
Laurent Gaudé inizia con questo monologo teatrale la sua esplorazione del mito, tagliando la carne viva dell’immaginario con parole affilate e impetuose. L’intimo così si scopre, fragile e vivo.
La traduzione ha beneficiato di una borsa di traduzione da parte dell’Association Beaumarchais/SACD (Francia).
Il testo è stato presentato in anteprima italiana in forma di mise en espace per la regia di Giancarlo Cauteruccio, con Fulvio Cauteruccio, Compagnia Krypton, al Teatro Studio di Scandicci il 21 aprile 2012 nell’ambito della rassegna “Face à Face Parole di Francia per scene d’Italia 2012”.
L’inizio della pièce
Non hai bisogno di un pretesto per venire a sederti accanto a me, sedie sono pubbliche e nessuno può pretendere di aver riservato proprio il posto che desideri tu.
Quindi non romperti la testa per formulare una falsa domanda, e chiedimi una sigaretta o l’ora solo se hai davvero bisogno di fumare o di sapere che ora è.
Siediti.
Ti domandi cosa ci faccia qui, sul binario di questa metro.
I convogli passano senza che io vi salga.
Ogni quattro o cinque minuti, centinaia di persone scendono dai vagoni e io non ne chiamo nessuna, non cerco con gli occhi nessuno.
E tu lo sai poiché mi guardi da tanto tempo.
Il mio viso è nero,
Sono sporco e rugoso.
Ho le labbra secche, così secche che se tutto a un tratto scoppiassi a ridere, si spaccherebbero e probabilmente del sangue sprizzerebbe fuori.
Ti domandi cosa attendo, chi sono.
Lascia che guardi a mia volta da vicino, prendendomi tutto il tempo, cosa può essere il volto di un uomo oggi.
Non aver paura,
Sono solo un vegliardo.
I miei occhi sono fragili per aver scrutato l’oscurità troppo a lungo, e questa strana luce blu del neon che lampeggia mi brucia l’iride.
Lascia che ti contempli, che veda se l’uomo è cambiato.
Non c’è più il fango
E sei pallido,
Così pallido che penserei di poter affondare un dito nella tua guancia e bucarne la superficie. Questa luce elettrica non scurisce la pelle come il sole?
Ora ti preoccupi e ti chiedi cosa possa davvero volere il vecchio…lo so…lo so…non guardarmi così. Vorresti fare una domanda, forse parecchie, ma non puoi.
Il mio volto e la mia voce ti fanno paura?
Ti ripugna la vecchiaia della mia pelle?
Non ti preoccupare, ringiovanirò.
Lascia passare tutta quella gente,
Lascia.
Nessuno fa attenzione a noi.
Ti domandi cosa sono e perché questa voce, che ascolti da qualche minuto e sulle prime era aspra e stridula, adesso ti incanti con una dolcezza che non ti spieghi.
Non ti preoccupare, compagno, ti racconterò tutto.
Finalmente ho trovato la città a cui appartengo.
Prima sono nato, poi ho errato alla ricerca di un posto a mia dimensione e solo adesso l’ho trovato, molto tempo dopo, quasi sul punto di morire.
Ma adesso lo so, e posso dire che sono nato per New York.
Ti racconterò tutto, compagno.
E ascolta bene perché sotto questo fascio di luce azzurrata, stai per sentire la storia di Onìsio furioso.
E dimentica quei grappoli di uomini e donne che si riversano sul binario, quelle orde di annegati
non ci disturberanno.
Onìsio parla.
Non vedi come sono già ringiovanito e quante rughe in meno conta il mio viso?
Sento il corpo che si riscalda, i muscoli sono più sodi,
Potrei denudarmi e vedresti che il mio corpo non è più quello di un vegliardo.
Potrei già quasi atterrarti nella lotta.
Ma prima lasciami parlare e non mi interrompere se le parole mi vengono lentamente, perché non ho parlato da così tanto che le labbra sono anchilosate per le migliaia di anni di silenzio.
CANTO I
Mi è difficile ricordare la mia terra natale.
Perché siamo qui in una città di luci dove i marciapiedi di bitume sono cosparsi di immondizia, di lattine di birra e carte sporche,
Dove gli uomini si accalcano a migliaia, dove le auto dalla mattina alla sera ruggiscono paraurti contro paraurti tra lo stridio di pneumatici impotenti
Quando laggiù, non c’era che un pugno di uomini e donne.
Mi è difficile ricordare quel villaggio perché il tempo è passato.
Ho fatto un sonno di parecchi secoli, una strizzatina di palpebre, appena, e New York è nata.
Tutti questi gran girasoli di vetro sono usciti dalla terra e hanno sprofondato il mio villaggio nel fondo della storia.
Sono nato a Tepe Sarab.
Tepe Sarab, compagno, dove gli uomini vivono in capanne di terra seccata, non più alte di un cavallo.
Sono nato a notte fonda e gli uomini del villaggio hanno dovuto accendere delle fiaccole per andare a vedere la testa di quel pezzettino di carne rossa che ansimando Ino aveva espulso fuori di sé. Ricordo la mia vischiosità mischiata al suo sudore.
Mi ricordo.
La mia memoria risale così lontano e posso ancora parlare delle casette di Tepe Sarab, nascoste tra le asperità dei monti Zagros.
Sono colui che non è nato da una donna.
Certo Ino mi ha tenuto nel ventre e Ino ha spinto perché uscissi tra le sue cosce,
Però mio padre è il signore degli dei e non occorreva una donna perché fossi proiettato nella polvere dei monti Zagros.
Di quelle prime ore, conservo dentro di me il ricordo del viso di Ino, spossata e livida.
Tepe Sarab,
Un piccolo villaggio circondato da muli e corvi.
Qualche capra salta di roccia in roccia e sale su dirupi inaccessibili agli uomini.
Talvolta, una si storce una zampa e rotola nel burrone,
Caduta d’aquila tra lo spavento ovino.
Varie settimane dopo la ritroviamo lacerata dalle rocce, puzza di morte e fa girare i corvi.
Talvolta scoppia una guerra.
Quattro o cinque uomini si armano di pietre e forconi e vanno a distruggere i tuguri del villaggio più vicino.
Chiamano quella una guerra.
Ino, in un’ultima contrazione febbrile, mi ha espulso sotto le stelle dei monti Zagros. C’è stata una grande festa.
A notte fonda, a Tepe Sarab, hanno fatto un rogo.
Gli uomini suonano della musica e le donne danzano.
Ino e Atamante sono ubriachi
La giovane madre si è rimessa.
Il sudore delle contrazioni si è asciugato in fretta.
Sono passate appena due ore, ma lei già non ci pensa più.
Vuole gioire e danzare e Atamante, il padre di carne, vuole bere e urlare.
Il grande falò, in mezzo al villaggio, illumina le facce di un bagliore di follia.
Il ritmo dei tamburi si mescola alle grida delle donne.
Vedo corpi impennarsi e fremere,
Vedo donne urlare di piacere e uomini rotolarsi nella polvere, e la polvere gli si incolla alla pelle tanto sono sudati.
C’è un gruppo di uomini che non danza.
Nessuno sa da dove sono venuti.
Qui non si conoscono.
Ma quelli di Tepe Sarab sono troppo ubriachi per preoccuparsi per quella presenza sconveniente, a notte fonda, nel profondo dei monti Zagros.
Loro non danzano, né bevono.
Non parlano con nessuno e nessuno di loro ha neppure guardato i corpi delle donne ondeggiare dal desiderio.
Forse non sono uomini e forse quelle grazie non li toccano?
Loro guardano il neonato.
Li vedo a qualche passo da me.
Uno di loro si alza e viene a porgermi un balocco di legno.
Devo ridere tra le fasce.
Nessuno vede che un uomo si è alzato e parla al neonato.
Si danza.
Ipnotismo dei tamburi.
Mi circondano adesso, sono cinque, forse sei, non so.
Mi circondano e nella mia infinita piccolezza capisco che non sono di Tepe Sarab, che non sono qui per danzare e bere e che, persino, forse, non sono uomini.
Uno di loro tira fuori un coltello da pastore.
Lo vedo chinarsi su di me e sento la lama aprirmi la gola.
Ma non è finita.
Ridono adesso, mi hanno ucciso.
Sulle fasce che Ino aveva gentilmente disposto attorno al mio corpicino, grandi macchie di sangue disegnano un violento mappamondo.
Non ho gridato, ma hanno fatto bene a cominciare con lo sgozzarmi perché se in seguito avessi potuto cacciare urla di dolore, avrei coperto il chiasso dei tamburi e fatto correre lungo la colonna vertebrale delle donne lunghi brividi di stupore.
Sento ancora le loro mani afferrare i miei arti.
Non sono più grande di un coniglio, ma non so correre.
Mi afferrano e tirano ognuna delle mie estremità.
La carne si squarcia e le ossa si rompono.
Una gamba, un braccio, una gamba, un braccio.
Sono un pezzettino di carne smembrato e sanguinolento.
I miei arti di lattante giacciono a qualche metro dal mio tronco, tra l’erba secca dei monti Zagros. Ma non è finita.
Gli uomini che non erano di Tepe Sarab non avevano danzato, né mangiato né bevuto.
E volevano, compiuto il lavoro, far festa a loro volta.
Allora hanno raccolto i pezzi di carne, li hanno fatti bollire in un paiolo di rame.
Li hanno lasciati cuocere a fuoco lento e ridendo hanno trangugiato lo stufato di neonato.
Sgozzato, squarciato e smembrato, il piccolo Onìsio è nato.
Ma gli imbecilli, nella loro pazzia, si sono dimenticati il cuore.
E a partire dal cuore, mio padre, perché è il signore degli dei, perché ha sentito le grida che non ho cacciato,
Con le sue mani di argilla mi ha fatto rinascere.
Non dormo di notte.
Se chiudo gli occhi, le stelle della notte di Tepe Sarab e i tamburi sincopati all’improvviso ricompaiono.
E le braccia, le gambe, le articolazioni e i muscoli mi tirano da ogni parte e si lacerano ancora.
Non dormo di notte perché ancora non mi sono vendicato degli uomini.
Ho lasciato per sempre Tepe Sarab.
Sono nudo e vivo come una belva, lontano dagli uomini che temo, nell’ombra opprimente delle montagne Zagros.
Ho errato da Behistun a Hamadan, ho errato fino a Tepe Giyan, prendendo in odio quei villaggi dove si danza.
La notte è il mio furore.
Nessuno ancora trema quando viene evocato il mio nome, perché nessuno, ancora, mi ha dato un nome.
Sono il lupo, il leone, l’orso e lo sciacallo.
Mi cimento in ogni ruggito.
Artigli mi spuntano sulla punta delle dita, ho i capelli arruffati.
Imparo a correre, affinché nessun uomo possa mai più afferrarmi.
Imparo a correre di notte tra Hamadan e Tepe Giyan, e le mie caviglie non si storcono mai, in nessuna delle anfrattuosità della roccia.
Vado più lontano della più selvatica delle capre.
Corro giù per i pendii di pietraie nella notte più buia, senza mai cadere, senza mai inciampare.
Sono nudo.
Le felci che attraverso in tromba mi eccitano la pelle con migliaia di piccole incisioni.
Ma questi graffi non intaccano le mie forze né rallentano la corsa.
Imparo a essere furioso e inafferrabile.
Ormai mi chiamo Onìsio ed è questo nome che imporrò agli uomini.
Sono il leone chiomato dei monti Zagros.
Sono nato, nato morto.
Solo, in mezzo alle felci e alle pietre, prendo forza per i miei combattimenti futuri.
Solo, nella notte mesopotamica, caccio i primi ululati di giaguaro che fanno fuggire gli animali e tremare le labbra delle donne.
Estratto dal testo inedito Onìsio Furioso di Laurent Gaudé, traduzione di Simona Polvani, depositato presso la SIAE (Italia) e la SACD (Francia).
Per ulteriori informazioni o se foste interessati a leggere il testo integrale: simona.polvani@gmail.com
Video di presentazione dello spettacolo Onysos le furieux, regia di Fanny Poulain, con Alexandre Loquet (France)
Video dello spettacolo Onysos The Wild, di Laurent Gaudé, traduzione di Adrian Penketh and Dominique Chevalier, regia di Severine Ruset, con Chris Porter (Inghilterra).
Parte I
Parte II